NON E’ EMPATIA, E’ PENA..
Nella nostra cultura occidentale le parole pena-compassione–empatia sono spesso usate come sinonimi. In realtà per quanto la sfaccettatura possa sembrare minima, il significato crea la differenza. Questo equivoco di fatto genera confusione e conflittualità quando vediamo qualcuno aver bisogno d’aiuto o stare in uno stato di sofferenza. Probabilmente anche per un condizionamento religioso/ culturale, essere testimoni della sofferenza altrui, ci fa sentire in colpa e ci attiva uno stato di soccorso. Quello che mentalmente ci diciamo, può anche non piacerci, ma in realtà è : poverino non ce la fa, lo devo aiutare. DEVO perchè mi ritengo superiore o più forte/fortunato, ma devo anche perchè così esco dal “fastidioso” senso di colpa. Questi due sentimenti si avvicinano perciò alla pena, intesa come pietas cristiana, ben lontana invece dell’empatia ..c’è una profonda discrepanza tra le due emozioni, per cui la pena fa si che si finisce con il rafforzare il ruolo di di vittima di chi ci si sta già infilando pericolosamente di suo. Purtroppo chi si sottomette a questo ruolo (di vittima), non sempre ha provato ad aiutarsi da solo, ma il solo pensarlo ci fa sentire “cattivi” o non approvabili, non capendo che invece è proprio questa la trappola che inibisce l’autonomia dell’altro, nonchè le sue risorse e la sua risoluzione. Nell’empatia come vediamo dal filmato c’è comprensione, fiducia e rispetto per la dignità dell’altro, così come il riconoscimento delle sue abilità di risposta (ovvero responsabilità dall’inglese respons-ability). Soprattutto c’è un’assenza di giudizio.
Il vero aiuto perciò non è indugiare nella pena, ma spostarci nella zona in cui l’aiuto per l’altro, si trasforma nell’abbattimento delle sue credenze di in-capacità. La pena rende tristi e blocca anche noi, la com-passione invece è la partecipazione interna allo stato emotivo dell’altro. L’empatia infine, è la risposta di comprensione e non è un caso che sia la base di tutti i processi d’aiuto, perchè è questa comprensione che attiva il vero cambiamento.
Abbiamo parlato in precedenza di quanto l’empatia, quando eccessiva, possa bloccare l’intelligenza. La pena può essere una di queste manifestazioni, forse la principale e diviene pericolosa quando facciamo in modo, seppur inconsciamente, che l’altro dipenda dal nostro aiuto, con la convinzione non ce la può fare senza di noi. Ma è davvero sempre così? Non si esprime in tal modo un rafforzamento della sfiducia che l’altro nutre in sè stesso? Se provare pena ci fa sentire “buoni”, non ci fa però agire al meglio: spesso chi è debole psicologicamente, non lo è concretamente; vive chiuso in una prigione mentale, ma non reale. E’ la percezione di sè perciò che crea il blocco, non la situazione pratica: una percezione erronea e limitante, dietro cui si nasconde talvolta anche per non assumere la responsabilità di agire, anche sbagliando, ma provando a venirne fuori. Il nostro aiuto quindi dà un sollievo momentaneo, ma continua ad inibirlo a lungo termine. Non favorendo il raggiungimento della sua autonomia, rafforza invece il fatto che anche noi lo percepiamo come in-capace, permettendogli uno stato di non azione e di deresponsabilizzazione. Ovviamente ci sono situazioni in cui provare pena è normale ed inevitabile, ma la maggior parte delle volte se guardiamo attentamente quel sentimento è sovradimensionato e diviene così paralizzante. Cadere perciò in facili indulgenze pulisce soprattutto la nostra coscienza, ma fa male nel tempo a chi la riceve. Il ruolo della vittima è uno dei ruoli più pericolosi in cui ci si può incastrare psicologicamente, in quanto viene molto facilitato dalle reazioni sociali, come abbiamo visto fin’ora. Molto spesso le persone che si lamentano di quanto vada male la loro vita, sono quelle che hanno fatto tentativi molto tenui per aiutarsi, o piuttosto, non ha tentato proprio nulla. La pena perciò può costituire una confort zone.
Non è un caso, che l’emozione provata a seguito del vittimismo altrui, può essere anche di rabbia o indignazione, seguita da un senso di colpa per averla provata. La commiserazione per l’altrui sorte è una specie di fuga da questi stati negativi: è sollievo dalla colpa. Tante volte sento parlare di emozioni conflittuali in queste circostanze, in cui rabbia e pena si mescolano o si alternano insieme. La rabbia deriva dal riconoscere che c’è qualcosa che stona in questa situazione: il vittimismo dell’altro infatti viene percepito in modo istintivo come una forma di manipolazione, in quanto abbassa la nostra risposta di rifiuto o di aggressività e perchè temiamo troppo di essere giudicati come cattivi. L’in-dignazione se guardiamo bene invece, è l’affermazione della dignità dell’altro e lo scioglimento del suo schema vittimistico. Come affermava Carl Rogers, primo grande teorico dell’empatia: ” La sola persona che non può essere aiuta è la persona che getta la colpa sugli altri. ..in ogni organismo c’è un flusso costante teso alla realizzazione costruttiva delle sue possibilità intrinseche, una tendenza naturale alla crescita”
Aiutare pensando al potenziale dell’altro, diviene quindi guidarlo fuori dalla sua prigione mentale, significa in-coraggiarlo, ed è un aiuto che può cambiare realmente una vita.
La nostra cultura in cui questi sentimenti sono mischiati e confusi, non solo non promuove, ma in una certa misura boicotta l’autonomia. Stimolare l’altro invece a provare, a rischiare, a creare una sorta di precedente, a fare anche piccoli tentavi, creandosi così maggiore sicurezza interiore, rafforzandosi, dimostrando a sè stesso che le sue convinzioni di im-potenza possono cambiare, vuol dire trasformare il suo atteggiamento di rassegnazione in un sentimento di coraggio. Significa in fondo: io mi fido che tu ce la possa fare.
Rebecca Montagnino


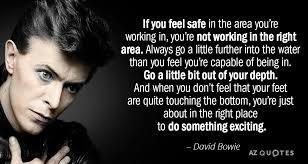
Commenti recenti